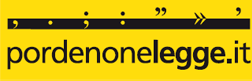Censimento dei poeti
Federico Italiano (Novara 1976) è ricercatore associato presso l'Accademia Austriaca delle Scienze a Vienna e docente di Letterature Comparate presso l’Università di Monaco di Baviera. Ha pubblicato cinque libri di poesia, Nella costanza (Atelier 2003), I Mirmidoni (Il Faggio 2006), L’invasione dei granchi giganti (Marietti 2010), L'impronta (Aragno 2014), Un esilio perfetto. Poesie scelte 2000-2015 (Feltrinelli 2015) e lo studio Tra miele e pietra. Aspetti di geopoetica in Montale e Celan (Mimesis 2009). Ha curato le raccolte di saggi Geopoetiche. Studi di geografia e letteratura (con Marco Mastronunzio, Unicopli 2011), Translatio/n. Narration, Media and the Staging of Cultural Differences (con Michael Rössner, Transcript 2012) e l'antologia di poesia italiana contemporanea Die Erschließung des Lichts. Italienische Dichtung der Gegenwart (con Michael Krüger, Hanser 2013).
Sito web: http://www.federicoitaliano.com
Post scriptum a Josif Brodskij
Sono nato e cresciuto tra le risaie piemontesi
dove onde minuscole screziano
la perfezione dei rettangoli e dei trapezi:
di qui la scarsezza di rime,
la voce d’amido che ricopre costante
la bolla emozionale, fragile.
La pianura non è infinita, lezione del sereno:
dal ponte di Romentino, le Alpi e il Rosa
confermano la possibilità del mito,
l’esuberanza, oltre il quotidiano.
Poiché non da pianura,
ma dal fronte dei monti fui edotto,
educato alla venerazione del mammut.
Scaglia di ghiaccio sopravvissuta al Pleistocene,
quest’io ch’è un noi idrico,
sguscia sotto i confini,
come Ticino il contrabbandiere,
dall’Iperuranio svizzero all’espiazione padana.
Da L’invasione dei granchi giganti (Marietti, 2010)
Questionario
-
1. In quale città hai studiato?
Milano e Monaco di Baviera -
2. Vivi in una città diversa da quella in cui sei nato? Per quale motivo?
Vivo da tredici anni a Monaco di Baviera. Motivi: cuore e lavoro.
-
3. Scrivi o hai mai scritto nella parlata, nel dialetto o nella lingua minore (scegli la definizione che preferisci) del luogo in cui sei nato e/o è avvenuta la tua formazione?
No, se si eccettuano alcune espressioni in novarese utilizzate in un paio di testi.
-
4. Quali studi hai intrapreso? Cosa hai studiato?
Laurea in Filosofia alla Statale di Milano. Dottorato di ricerca (PhD) in Letterature comparate alla LMU di Monaco di Baviera.
-
5. La tua laurea o il tuo titolo di studio hanno a che fare con il lavoro che svolgi?
Sì. Sono docente di Letterature comparate a Innsbruck e a Monaco di Baviera.
-
6. Svolgi un lavoro che ha, in qualche misura, a che fare con la tua attività di poeta?
Insegnando Letterature comparate, tratto molto spesso di poesia e offro, quando è possibile, corsi sulla poesia contemporanea.
-
7. Quali lingue conosci?
Italiano, tedesco, inglese, spagnolo, francese, latino e greco. Ho un’infarinatura di portoghese e sto studiando (con molta calma) l’ebraico.
-
8. A quali lingue accedi in originale per leggere le poesie?
Italiano, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese.
-
9. Che cosa pensi dell’insegnamento della poesia nella scuola?
Imprescindibile.
-
10. Al di là dell’interesse legato alle tue esigenze di informazione, ti piace leggere libri di poesia?
Sì, moltissimo.
-
11. Puoi quantificare il numero annuale?
In un anno acquisto in media una ventina di libri di poesia, ma penso di leggerne almeno il triplo, considerando le consultazioni in biblioteca, le copie in omaggio (sempre ben accette), e le riletture degli autori più cari.
-
12. Quale genere di altri libri ami leggere?
In ordine di frequenza: Saggi, romanzi, opere teatrali, diari di bordo, antologie e florilegi vari, atlanti, dizionari etimologici, libri di cucina, cataloghi, vecchie enciclopedie, manuali, ecc.
-
13. Qual è il tuo rapporto con la letteratura classica antica (greca e latina)?
Ci sono autori che non smetto mai di leggere, come Omero e Ovidio; altri cui ritorno spesso, come Sofocle, Virgilio, Orazio, Tacito; di altri ancora, come Apollonio Rodio o Luciano di Samosata, parlo volentieri a lezione; ma curiosamente lo scrittore che ho citato di più negli ultimi tempi è Plinio il Vecchio.
-
14. E con i classici dell’Otto e Novecento?
Che dire? Sono i testi su cui mi sono formato, con cui continuo a confrontarmi come scrittore e di cui mi occupo costantemente come critico e docente.
-
15. Quali sono i poeti della tradizione novecentesca che ritieni essenziali per la tua formazione poetica? Per quali motivi?
Eliot per la visione; Montale per lo stile (e un po’ per tutto il resto); Auden e Sereni per l’intelligenza poetica; Celan per l’implacabilità; Heaney e Zanzotto per il senso del luogo; Walcott per il respiro; Muldoon (sebbene non si esaurisca nel Novecento) per il divertimento nel comporre.
-
16. E quali sono le tre opere poetiche pubblicate a partire dal 2000, e scritte da poeti nati dagli anni ’70 in poi, che per te sono particolarmente importanti?
Una terna rappresentativa potrebbe essere la seguente: “Nome e soprannome” di Cattaneo, "Ogni cinque bracciate" di Frungillo e "Kamikaze e altre persone" di Annovi.
-
17. Ti occupi di promuovere la letteratura e la poesia attraverso iniziative pubbliche?
Soprattutto in ambito editoriale e accademico.
-
18. Quale ruolo hanno la rete e i social network nel tuo occuparti di poesia?
Leggo spesso blog letterari e riviste online. Partecipo però di rado attivamente a discussioni e iniziative in rete.
-
19. Hai un blog?
No -
20. Collabori per riviste on line e/o cartacea?
Collaboro soprattutto (ma non esclusivamente) con riviste e pagine culturali cartacee.
-
21. C’è, nella tua opinione, spazio per un ruolo pubblico del poeta nella società di oggi?
Non mi pare vi siano oggi i presupposti perché un a poeta possa essere riconosciuto un ruolo pubblico di peso proporzionale al valore della sua opera. Questo non significa, però, che un poeta non sia in grado di conquistarsi tale posizione per meriti extraletterari o incentivi mediatici.
-
22. Conosci realtà diverse dalla nostra, per quanto riguarda il ruolo pubblico dei poeti, fuori d’Italia?
In Irlanda mi pare vi sia ancora molto rispetto e amore per la figura del poeta. In Germania, invece, non vedo una situazione radicalmente diversa da quella italiana, fatta forse eccezione per la maggiore serietà (anche economica) dei premi letterari e delle borse offerte agli scrittori. -
23. Pensi che si potrebbe intervenire sulla politica culturale attuale e, se sì, in quale modo?
Credo che sia fondamentale, ancora oggi, promuovere la poesia innanzitutto nelle università. Non si può pretendere che tutto un paese riscopra quanto sia bella e utile la poesia, ma non è nemmeno accettabile, ad esempio, che la maggior parte degli studenti di Lettere si laurei senza una minima conoscenza della poesia italiana contemporanea.